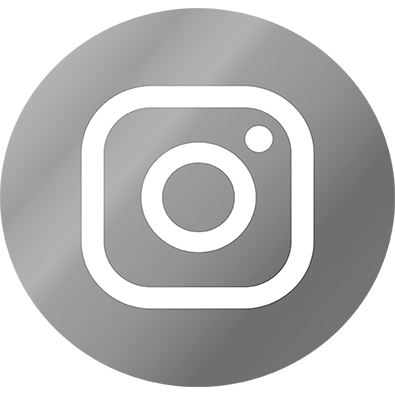PENTESILEA
Ultima Regina del proprio esclusivo Io, solitaria amazzone senza più arco, addenta e sbrana se stessa con la voluttà delle parole in versi e con le frecce appuntite degli autoritratti photo booth di un powerbook. Autrice live della propria serializzazione dentro il box del tempo presente – grafìa che fissa il momento dell’atto e del sentimento autorale – autoedifica il dialogo, il combattimento tra l’Io presente e l’Io appena impresso, dilaga sul campo di battaglia scomponendosi in dialogiche relazioni conflittuali, amorose, rancorose, ai limiti dell’assassinio del Sé, del Selbst che tutto comprende. Il corpo fisico appare, si libera dell’involucro teatrale e opera al MacLibro come alla consolle della propria vita. L’acqua del bicchiere l’annega dentro l’immagine ingrandita in uno schermo nero palcoscenico/bocca che tutto ingoia e il libro d’acciaio si fa affilato e appuntito come un coltello.
Perché adesso scendo nel mio seno, come un pozzo, e scavo fuori, freddo come un metallo, un sentimento che mi distrugge.
Questo metallo, lo purifico nel fuoco di un grido di dolore duro come l’acciaio; poi lo bagno con il veleno acido del pentimento, da parte a parte; lo porto all’incudine eterna della speranza, e lo affilo e lo appuntisco in un coltello; e a questo coltello adesso offro il mio petto: Così! Così! Così! Così! E ancora! – Ora va bene.
Il sole ad “O” dell’icona luminosa tramonta spegnendosi a poco a poco come il tempo vissuto dall’attrice e i suoi doppi photo booth. Kleist alla cugina Maria von Kleist: “Ho portato a termine la Pentesilea. E’ vero, c’è dentro la mia più intima natura … tutta la sozzura e ad un tempo lo splendore dell’anima mia.”
Alla ricerca del respiro che precipiti la parola nel pieno di fronte a sé l’attore si sospende – stupito – nel vuoto che la parola stessa creerà. Parola nata nel ventre, risalita ancora muta alle corde vocali, nemica al cervello, parola che cerca un’uscita attraverso i buchi della carne. Quando si forma? Quando si dà forma? Dentro, fuori? L’attore espone il corpo, la parola è lì dentro, rinchiusa muta e ci guarda dal corpo, dagli occhi ci spia e ci avverte che potrebbe non uscire mai. Quando e come lo decide lei. Il corpo dell’attore la contiene soltanto e dentro rimbalza, scalcia, si nasconde, gli provoca sofferenze terribili, lo mastica tutto, ora in fretta ora lenta, la lotta è iniziata e l’attore lo sa. Sa che una volta fuori scomparirà nel suo vuoto, che sarà l’unica e l’ultima, che lo abbandonerà lì, solo, involucro innocuo come un pupazzo. “Qui tu resti, e senza suono (lautlos). Quando tutto il corpo è sprofondato all’altro mondo, quello vero del teatro, allora è uscita bella e pulita, sacra e pura, sfrontata e giusta. Il corpo dell’attore ha aperto la porta, ha varcato la soglia, le ha permesso l’ingresso, si è reso trasparente per lei, le si è offerto.
Questo è il sacrificio dell’attore, portare dentro di sé il seme, dal primo giorno di prova, sentire la crescita dentro di sé, la pulsazione, il ritmo di un cuore nuovo, contenere la nuova vita fino all’attimo della nascita che la parola decide da sé. Il lavoro dell’attore deve essere fatto di continui “da capo”, il corpo deve ripulirsi di ogni incrostazione, di ogni finta postura, dell’affettazione, della superficie del quotidiano. In questo lungo processo di purificazione la drammaturgia subisce modificazioni radicali, si muta nell’evolversi della crescita della parola, nel realizzarsi della nuova coscienza dell’attore.
Il compito del regista è di predisporre il corpo dell’attore a ricevere la parola, di condurlo ad abitare la scena della nascita, di aiutarlo ad essere solo quando la parola lo svuoterà. Il corpo dell’attore in solitudine contiene in sé lo sguardo del regista, gli occhi, le mani, le gambe si moltiplicano. Il regista è solo l’autore di questa moltiplicazione, sta qui la sua necessità. L’attore è femmina, come dice giusto Valère Novarina. Solo il corpo femminile può crescere una parola che al suo apparire abbia i colori della nascita. Solo gli occhi di una donna possono portare nello sguardo la furia di Pentesilea, il ritmo micidiale di un’Amazzone. Al maschio non resta che fingere, nella verità del corpo in scena, di non essere un appestato, di essere un soldato, di essere un eroe. Kleist ha chiesto a una donna di aiutarlo a porre fine alla finzione.
da Pentesilea di Heinrich von Kleist
traduzione | drammaturgia | Francesco Pititto
regia | installazione | costumi | Maria Federica Maestri
musica | Andrea Azzali_Monophon
interprete | Sandra Soncini
produzione | Lenz Rifrazioni
Lenz Rifrazioni: la ricerca del contemporareo
Di Andrea Porcheddu, Linkiesta, 14 marzo 2013
Di cosa parliamo quando parliamo di teatro contemporaneo? Sembra un titolo carveriano, oppure un dubbio di monsieur Lapalisse.
A voler liquidare la questione in fretta, in due minuti, bastano tre parole: il teatro che si fa nel nostro tempo. Sono otto parole, ma meno di due minuti.
Però a ben vedere, è una domanda trabocchetto.
L’altra sera sono andato a Parma. Erano tanti anni che non ci tornavo. L’occasione era un duplice invito della compagnia Lenz Rifrazioni. Il gruppo, chiamato da tutti Lenz, guidato da Maria Federica Maestri e Franscesco Pititto, è da anni un protagonista indiscusso della ricerca teatrale italiana. Il suo linguaggio, spesso estremo, sempre concettuale, non esclude il confronto con fisicità aspre – quelle che Romeo Castellucci chiamava le “bellezze dimenticate” – ossia quell’ampia umanità spesso marginale che vive le dinamiche della diversità.
La ricerca di Lenz, insomma, da sempre in quel teatro bellissimo ricavato con coraggio e dedizione in un capannone industriale, è profondamente radicata nelle tensioni e nelle contraddizioni del nostro tempo.
Gli spettacoli, dunque, erano due. Il primo è un monologo, affidato alla ottima Sandra Soncini, che attraversa il mito di Pentesilea nella vertigine compositiva di Kleist. Un monologo inesorabilmente detto di fronte allo schermo del Mac, che moltiplica e ingigantisce il primo piano sul fondo. Pentesilea sola con se stessa, regina disarmata, si martorizza in chat: fino a divorare il proprio mito come un bicchier d’acqua. È un racconto che si fa delirio, ossessione, auto-dialogo di chi disperatamente cerca nel bagliore dello schermo tracce di vita, aiuto, ascolto.
Poi, un lavoro più complesso e articolato, Aeneis in Italia, che affonda nell’Eneide come un coltello, traendone una essenza amaramente italiana, capace di unire la leggenda del padre fondatore di Roma con la lotta armata anni Settanta.
Lenz ha fatto un grande percorso pluriennale sull’opera di Virgilio, diviso in capitoli corrispondenti ai libri dell’Eneide, proprio per riflettere sui miti fondanti la “Patria” (le virgolette, vista la situazione italiana, mi sembrano d’obbligo).
Ho visto gli ultimi capitoli – dal 7 al 12 – affidati a tre corpi nudi, impiastricciati di bianco, due uomini e una donna. Essi giocano, lottano, litigano, si scontrano, saltano, danzano, parlano. Sono stridori, amplificati dal cupo suono – elaborato live da Andrea Azzali – che fa dell’Eneide una partitura della sofferenza, una storia mitica che invece racconta bestialità, violenze, sopraffazioni. Nell’eterno ritorno dell’uguale di un italietta sempre devastata, ingrigita, volgare.
Dopo il suggestivo e inquientante Hamlet nell’enorme spazio del Teatro Farnese, Lenz continua dunque a rimescolare le carte del classico e del mito, riformando radicalmente il canone all’insegna del contemporaneo.
Ecco, dunque, perché mi chiedevo cosa fosse il contemporaneo e quando il teatro contemporaneo cessa di essere tale.
Possiamo dire, banalmente, che il teatro è contemporaneo a se stesso, al suo tempo? Ecco, qui si insinua il dubbio. Chi si occupa di arte contemporanea, sa che in fondo ha a che fare con la questione del Tempo. Lo ricorda molto bene Federico Ferrari, nell’introduzione a un agile volume dal titolo significativo di “Del contemporaneo“. Il teatro sembra essere contemporaneo quasi per definizione: quante volte abbiamo sentito parlare di hic et nunc, dell’essere cioè presente e vivo proprio nel momento in cui sono due comunità – quella degli attori e quella degli spettatori – che si incontrano. Lo sguardo, il corpo, la parola sono gli elementi connotanti di quell’essere presenti all’evento scenico, che è dunque un tempo condiviso. Ma ciò non risolve la domanda iniziale. Cosa è il teatro contemporaneo e perché ha a che fare con il tempo. Ferrari ricorda che noi, noi specie umana, siamo nel tempo: nasciamo entrando nel tempo e moriamo uscendo da esso. È, sostanzialmente, parafrasando Malraux, la “condizione umana”. Tanto che tutti i filosofi – da Parmenide a Heidegger a Nieztsche a Giorgio Agamben – si sono interrogati sulla domanda fondante, che cosa è il tempo: fulcro del pensiero filosofico e dunque fulcro del pensiero e della prassi artistica. In questa prospettiva – riassumo e faccio mio il pensiero di Ferrari, mi perdonerà spero l’autore – i “classici” si siedono sul bordo del tempo, e aspettano che passino le mode, le tendenze, le frenesie del momento. Portano valori e canoni – alcuni direbbero archetipi – eterni, che eternamente ritornano. Dall’altra parte, invece, l’arte contemporanea: il nuovo che avanza, che si tuffa nel tempo, e lo racconta, instancabile nel suo essere cangiante, mutevole.
Sono forme dicotomiche? Conflittuali? Sì, spesso lo sono. Il classico perde di vista il reale, certo contemporaneo invecchia subito. Ma c’è infine un altro modo di essere classico e contemporaneo: un modo per cui il fermento rinnova il classico e il classico conferma il fermento. Oggi viviamo in un tempo di teatro accelerato: nella durata, nella produzione, nella fruizione. Ce lo racconta bene Thomas Ostermeier cui dobbiamo questa definizione: è un teatro che vive della accelerazione comunicativa, sociale e al tempo stesso contribuisce a riflettere sul tempo presente. Eppure in questa accelerazione, il teatro non ha perso di vista il suo rapporto col Tempo. Mi piace riprendere, a questo proposito, una ormai celebre definizione di Agamben sul contemporaneo: «è contemporaneo chi non coincide effettivamente con il suo tempo né si adegua alle sue pretese ed è, perciò, in questo senso, inattuale. Ma proprio attraverso questo scarto e questo anacronismo, egli è capace più degli altri di percepire e afferrare il tempo».
Ecco allora, cosa è il teatro contemporaneo. Quel teatro “fuori” dal tempo presente per una piccola, lieve sfasatura. Un punto di vista, una prospettiva, una capacità narrativa. Ci dice Jean Luc Nancy, nello stesso libretto citato, che le opere contemporanee dunque non solo ci obbligano ad assumere quello sguardo trasversale su di noi e sul nostro tempo, ma ci spingono, sempre di nuovo, a porci l’incessante quesito su cosa sia il contemporaneo. Ovvero, attraverso il nostro sguardo – che è uno sguardo curvo, che ritorna su di noi attraverso lo sguardo dell’attore – il contemporaneo ci impone la domanda su cosa sia l’arte, ovvero il teatro, che stiamo vivendo, ovvero cosa sia il mondo, e la società che stiamo vivendo. Con Lenz Rifrazioni, con altre compagnie e gruppi italiani, questo accade.