
VERDI RE LEAR
PROGETTO PER IL FESTIVAL VERDI 2015
Continua l’esplorazione della drammaturgia shakespeariana con un nuovo capitolo performativo-musicale dedicato al Re Lear – nel binomio Verdi/Shakespeare. Nella cornice del Festival Verdi 2015, Lenz realizza un’opera musicale e visuale contemporanea sul Re Lear, l’opera ‘assente’ di Giuseppe Verdi, che vede rinnovata ed ampliata un’importante collaborazione artistica con il compositore di musica elettronica Robin Rimbaud aka Scanner e il Conservatorio di Musica “A. Boito” di Parma.
- Foto
- Intro
- Credits
- Conversazione su Verdi Re Lear
- Teatri del Suono
- Robin Rimbaud aka Scanner
- Video
- Press
- Brochure
«È un’ulteriore, audace e potente indagine drammaturgica tra passato e presente, tra memoria e contemporaneità, quella compiuta da Maria Federica Maestri e Francesco Pititto, progetto attorno e dentro a un’opera che non esiste, della quale si hanno tracce sparse, indizi frammentati. L’incompiuta è il Re Lear di Giuseppe Verdi, opera mai musicata e di cui esiste solo il libretto di Antonio Somma contenente le correzioni dello stesso compositore. Opera sempre desiderata, tesa a scavare nell’animo della figura del re/padre/folle, ma mai portata a compimento». Il noto critico teatrale Giuseppe Distefano, dopo la prima presentazione di Verdi Re Lear – L’Opera che non c’è_Premessa alla 19a edizione del Festival Internazionale Natura Dèi Teatri nel dicembre scorso, annota: «La visione pittorica-installativa è la silhouette di un gruppo immobile disposto attorno a un trono posto sul fondo della scatola scenica e reso evanescente dai tre velari trasparenti dove, a più livelli di proiezioni, scorrono le immagini di un uomo, Lear, di cui udiamo la voce. Sui dettagli del suo corpo, raggomitolato o accasciato, indugia l’occhio della telecamera quasi a farne una mappatura, indagandone i moti e le ferite dell’anima […] Trovano altri momenti di autentica emozione le plastiche deposizioni dal trono a terra, il lento incedere e posizionarsi, il trascinare una corda al guinzaglio e le “arie” sparse – nel finale dal Simon Boccanegra, “Come in quest’ora bruna…” – che costellano l’universo verdiano sulla tragedia della paternità, resa da Lenz epifania scenica del desiderio».
Verdi Re Lear abita le due grandi sale di Lenz Teatro, con il pubblico dinamico invitato a transitare fra i due spazi. Maria Federica Maestri, che dello spettacolo cura drammaturgia dello spazio, installazioni e costumi, suggerisce i motivi di questa scelta inconsueta: «La concatenazione temporale di due piani spaziali separati conserva ed esalta la duplicità dell’immagine semi-virtuale di quest’opera che collega reale e non reale, tracce e desideri: la materialità dei corpi, dialogando con l’immaterialità dell’immagine, genera un’immagine-sogno. Costruita per strappi, sottrazioni e salti, l’immagine semi-virtuale produce un continuo sganciamento dall’immagine coerente del mondo; analogamente gli spettatori in fruizione delocalizzata, in transito soggettivo, nel passaggio da spazio a spazio, perdono l’unità e la linearità drammatica della visione tradizionale, e in totale assonanza con la forma artistica del lavoro – dare forma scenica ad un desiderio – ricompongono una propria personale opera-ricordo».
Conclude Francesco Pititto, responsabile di ricerca, drammaturgia, imagoturgia e regia di questo progetto siderale: «Dare forma a un desiderio, dopo averne scandagliato gli impulsi primari e le manifestazioni più nascoste, è percorso affascinante di ogni ricerca linguistica; vestire un fantasma e vederlo muoversi solo attraverso il movimento delle stoffe è già averlo consegnato al mondo reale che, shakespearianamente, è fatto di sogni e di niente».
La consulenza musicale per la selezione dei brani di repertorio di Verdi Re Lear è del M° Carla Delfrate, la consulente al canto è la Prof. Donatella Saccardi. Performer: Valentina Barbarini (Cordelia/Delia), Barbara Voghera (Fool/Mica), Giuseppe Barigazzi (Lear in immagine). Cantanti: Haruka Takahashi (Regan/Regana, soprano), Ekaterina Chekmareva (Goneril/Gonerilla, mezzosoprano), Gaetano Vinciguerra (doppio Lear, baritono), Lorenzo Bonomi (doppio Lear/Edgar/Edgardo, baritono), Andrea Pellegrini (doppio Lear, basso), Adriano Gramigni (Gloucester, basso). Voce over di Rocco Caccavari. In scena Rocco Caccavari, Paolo Maccini, Franck Berzieri, Carlo Destro e Paolo Pediri. Assistente alla regia: Valeria Borelli. La direzione tecnica è di Alice Scartapacchio, la produzione è di Lenz Fondazione. Verdi Re Lear è realizzato in collaborazione con il Conservatorio di Musica “A. Boito” di Parma.
Enrico Pitozzi su Verdi Re Lear
Spectra | Anatomia per un teatro di voci
Ci sono sempre almeno due piani dell’immagine.
Uno rimanda al regime del visibile, l’altro a quello sonoro. L’uno, quello del visibile, agisce nell’immediato; per questa sua caratteristica è localizzabile, visibile appunto. L’altro, quello sonoro, è connaturato da una certa discrezione, agisce come nell’ombra, in modo diffuso, si esprime nella durata; per questa sua caratteristica non è localizzabile, non possiamo con esattezza stabilire da quale punto dello spazio proviene. È acusmatico, la sua peculiarità non è l’evidenza, bensì la profondità; la sua logica non è quella dell’evento, bensì quella dell’efficacia.
II. Si potrebbero così sintetizzare, a mio modo di vedere, i tratti che illuminano la versione del Re Lear di Verdi – ispirato a Shakespeare – che Lenz Rifrazioni – ora Fondazione porta in scena per il centenario verdiano. Lavoro di cui esiste il libretto, ma non la partitura musicale. Esistono le parole, non la loro temperatura sonora. Siamo così, dice bene Lavagetto, di fronte a “Il fantasma di un’opera”.
Fantasma, infatti, deriva dal greco ϕάντασμα e organizzato intorno a ϕαντάζω «mostrare», ϕαντάζομαι «apparire». Da un lato, tale declinazione rimanda al farsi immagine di qualcosa che non ne ha ancora lo statuto. Dall’altro, invece, fantasma dice di qualcosa che «accenna», «suggerisce» senza dire pienamente, lascia intravedere perché testimonia un’incompiutezza, o meglio la pervasività di un tema che ha segnato tutta la produzione di Giuseppe Verdi; solo che l’ha fatto sottotraccia, come una scossa intensa e diffusa, fino ad abbracciare molta della sua produzione operistica che, a differenza di questo Lear incompiuto, ha visto la luce.
Dunque è in questo territorio fatto di frammenti sparsi, detriti, elementi magnetici e ritorni che si disegna la costellazione che sta intorno alla versione di Lenz. Per questa ragione ne deriva un Re Lear fantasmatico, in cui sia la composizione scenografico-installativa firmata da Maria Federica Maestri, che l’imagoturgia di Francesco Pititto, lo enunciano dichiaratamente, dando luogo a una continua sfocatura – un’impossibilità a vedere chiaramente – che produce sospensione, come in una evocazione o una evaporazione: in ogni caso, un’epifania inattesa.
III. Qual è allora la strategia che Lenz adotta in questa visione verdiana? Rispondere a questa domanda ci rimette in linea con il punto di partenza, con i due piani dell’immagine sopra evocati.
Il sospetto è che Maestri e Pititto lavorino per sottrazione – altra componente operativa del pensiero musicale verdiano; una sottrazione che libera la forza trascinante della musica, là dove la parola del canto diventa sonorità, phoné: materia che dice, prima e oltre il significato stesso della parola, la pulsione sonora della voce. Ne è prova quella che potremmo definire, sulla scorta di Roland Barthes, una scrittura ad alta voce alla quale Verdi, ricordiamolo ancora – di questo Lear manca interamente la partitura musicale, ma ne esiste il libretto – sembra guardare e che Lenz rimarca nella messa in scena: l’elemento musicale è la voce stessa, essa non è accompagnata da nessun suono che non sia espressione della vocalità.
Quella di Verdi, in altri termini, è la composizione vera e propria di un coro di voci, materia sonora attraverso la quale liberare la potenza creatrice della musica. Ed è qui che Lenz compie un passo decisivo nella direzione di Verdi – perché di questo si tratta, di un Re Lear concepito nello spirito della musica di Giuseppe Verdi. I cantanti presenti in scena – due attrici in funzione di Fool/Mica e Cordelia/Delia, un attore Lear in video, due baritoni a dar forma al doppio Lear in scena, una soprano Nerilla, e una mezzosoprano Rosane/Delia – sono disposti come attivatori sonori, voci che letteralmente appaiono come da un aldilà, figure che attualizzano la potenza del canto. C’è un velo, al contempo materiale – il tulle – e immateriale, quasi metafisico, che accompagna questo lavoro.
Non saprei come nominarlo se non riconducendolo al pulsare della vita, perché chiama in causa l’esistenza stessa: c’è qualcosa che tocca il fondo della vita e il suo prolungamento, così come la ragione e i suoi processi, è una sorta di vittoria contro la morte ad essere evocata in scena, perché non c’è altra verità se non questa coincidenza con il presente, sempre però con un leggero scarto, come di lato, come a segnare – nonostante tutto – una mancanza, un non ancora, un incompiuto.
Perché questo?
Perché la musica qui, nella geometria del pensiero verdiano, è l’immagine della ragione o meglio, come dice Gille Deleuze, la ragione in atto. La musica ha il potere – e questa messa in scena di Lenz lo rivendica a più riprese – di innestare il movimento delle cose; fa letteralmente esistere le cose a partire dal loro fondo oscuro, innominabile. Sospende il tempo, ritarda il disastro.
A dare forza a questo divenire delle forme che si susseguono in scena, si innesta la collaborazione con il sound artist Robin Rimbaud aka Scanner che, sulla scia del pensiero librettistico, elabora una serie di composizioni sonore, in un concatenamento che non è pensato per accompagnare il canto, piuttosto per delineare quella che potremmo chiamare una vera e propria dimensione sonora dell’immagine: l’immagine sonora – il suo potenziale atmosferico – è quella che dà la texture di fondo alla scena e in base alla quale l’immagine visiva si definisce. Dunque, così come esiste un’immagine visiva, sulla scena di Lenz sembra emergerne con forza una di tipo uditiva. Non si tratta qui soltanto di cogliere ciò che si manifesta all’udito: questa immagine alla quale Scanner contribuisce, ha a che fare con ciò che sta dentro l’ascolto, bisogna individuarne le caratteristiche e il punto raccolto nel quale agisce l’intensità che fa di una materia sonora un’immagine e che, di conseguenza, ridisegna i caratteri dell’ascolto. Apre lo spazio perché la voce, in scena, possa lasciare traccia. Fuggevole, s’intende, come un bagliore. Una macchia di luce su un fondo antracite. È dunque il suono – nella doppia prospettiva del Teatro di voci e dell’atmosfera acustica – che detta la temperatura, l’accordatura tra gli elementi della scena. In questa cornice l’immagine visiva ne è il contrappunto, un piano, un punto di fuga.
IV. Lo spettatore è così posizionato idealmente all’interno di questo perimetro sonoro, di fronte alla visione, posizione dalla quale è possibile avvertire tutte le loro varianti, le loro impercettibilità. Partendo da questo punto raccolto nel suono – da quella che abbiamo chiamato immagine acustica – ricostruire la musica che il suono nasconde. Forse è proprio questa la sfida che Lenz raccoglie con questa messa in scena impossibile. Impossibile perché, letteralmente, è oltre ogni possibilità: nucleo magmatico, indefinito, al quale tentare – nonostante tutto – di dare una forma.
Non resta, a questo punto, che risolvere l’ultimo passaggio: di che ascolto parliamo, dunque, con questa opera?
Ascoltare qui, come in altre produzioni di Lenz, è un divenire: divenire suono, divenire fonema, materia, pulsazione vocale. Seguire questo processo richiede un’estensione percettiva dell’ascolto, un lasciar penetrare il suono e divenire, al contempo, suono nell’ascolto. Solo così l’imagoturgia – la logica della visione delle immagini – acquisisce la sua piena efficacia: agisce in modo latente.
Serve dunque un corpo timpano, un corpo prisma, per percepire questi fantasmi: solo un orecchio impossibile capta l’inudibile; solo un occhio capace di penetrare le forme vede davvero e per l’ultima volta ciò che gli sta di fronte.
VERDI RE LEAR
da Re Lear di Somma-Verdi prima versione con le varianti e King Lear di William Shakespeare
Ricerca, drammaturgia e imagoturgia, regia | Francesco Pititto
Music + live electronics | Robin Rimbaud aka Scanner
Installazioni e costumi | Maria Federica Maestri
Consulenza musicale | M° Carla Delfrate
Consulente al canto | Prof. Donatella Saccardi
Performer | Valentina Barbarini, Barbara Voghera, Giuseppe Barigazzi
Cantanti | Haruka Takahashi, Ekaterina Chekmareva, Gaetano Vinciguerra, Lorenzo Bonomi, Andrea Pellegrini, Adriano Gramigni
Voce over | Rocco Caccavari
In scena | Rocco Caccavari, Paolo Maccini, Franck Berzieri, Carlo Destro, Paolo Pediri, Marco Cavellini
Cura | Elena Sorbi
Organizzazione | Ilaria Stocchi
Comunicazione | Violetta Fulchiati
Ufficio stampa | Michele Pascarella
Direzione tecnica | Alice Scartapacchio
Assistente alla regia | Valeria Borelli
Équipe tecnica | Gianluca Bergamini, Gianluca Losi, Stefano Glielmi, Marco Cavellini
Produzione | Lenz Fondazione
In collaborazione con Conservatorio di Musica “A. Boito” di Parma
CONVERSAZIONE SU VERDI RE LEAR
Ridotto del Teatro Regio di Parma
venerdì 2 Ottobre 2015, ore 17.30, ingresso libero
Il Lear incompiuto, mai musicato ma sempre desiderato, è presenza virtuale in diverse opere di Giuseppe Verdi. La sua sagoma si proietta su Rigoletto, Luisa Miller, Il trovatore, Nabucco, La forza del destino, a testimoniare e il desiderio insoddisfatto di scavare nell’animo più intimo e umano del re/padre/folle.
Con la partecipazione di FRANCESCO PITITTO, MARIA FEDERICA MAESTRI,
CARLA DELFRATE, DONATELLA SACCARDI
Teatri Del Suono > Convegno su Verdi Re Lear
Lenz Fondazione per Festival Verdi 2015
TEATRI DEL SUONO
Il 13 ottobre dalle ore 16 alle ore 19 ha luogo a Lenz Teatro il convegno Teatri del suono, coordinato da Enrico Pitozzi (Docente presso l’Università di Bologna), con la partecipazione di Maria Federica Maestri e Francesco Pititto (Lenz Fondazione), Robin Rimbaud aka Scanner (Compositore), Massimo Marino (Docente presso il Conservatorio Arrigo Boito di Parma), Helga Finter (Docente presso l’Università di Giessen – Germania) e Marco Capra (Docente presso l’Università di Parma e vicepresidente dell’Istituto Studi Verdiani).
Curatrice: Valeria Borelli.
L’attenzione che la scena attuale riserva alla composizione sonora, contribuisce a rimettere al centro della riflessione il potenziale drammaturgico del suono. Ciò corrisponde ad affermare che il teatro contemporanea, nelle sue diverse manifestazioni, ha elaborato un pensiero sonoro autonomo, che eccede il quadro di riferimento della «musica di scena», delineando i contorni – ancora tutti da definire – di un Teatro del suono. Tale cornice – di cui la messa in scena del Re Lear, di Giuseppe Verdi (di cui esiste il libretto, ma non la partitura musicale) ad opera di Lenz Rifrazioni, in collaborazione con Robin Rimbaud aka Scanner, ne offre occasione di discussione – investe non solo la prosa, ma si misura anche con il repertorio del Teatro d’Opera, interpretato secondo lo «spirito della musica». Inoltre, in questo quadro, cambia la concezione e l’utilizzo della voce in scena. Seguendo la forza trascinante della musica, la parola e il canto si offrono all’ascolto come phoné: materia sonora che trascende il significato stesso della parola. La scena diventa così un ambiente sonoro diffuso, che lo spettatore è chiamato ad abitare.
Enrico Pitozzi, Università di Bologna
Scanner, nome d’arte del musicista, scrittore, artista e critico inglese Robin Rimbaud, è sinonimo di sperimentazione tra le arti e di uno stile unico nel panorama musicale ed artistico internazionale. Il musicista attraversa i territori sperimentali tra suono, spazio, immagine e forma creando una piattaforma sonora multi-livello che sfrutta la tecnologia in modo non convenzionale. E’ considerato tra i compositori più importanti della scena elettronica mondiale. Nei suoi primi controversi lavori usava lo scanner, uno strumento di intercettazione radio, per realizzare le sue composizioni musicali. Brani di conversazioni di telefoni cellulari di ignari utilizzatori, servizi civili come ambulanze o servizi di sorveglianza vengono campionati e inseriti nella musica dell’artista come parte integrante di un tappeto di suoni. Questo percorso, che intendeva scoprire i suoni nascosti nelle moderne metropoli, ha ricevuto l’ammirazione di artisti come Bjork, Aphex Twin e Karlheinz Stockhausen. Scanner ha collaborato con artisti di diverso genere: dai Radiohead a Bryan Ferry e Laurie Anderson, dalla Rambert Dance alla Random Dance Company, il Royal Ballet e Merce Cunningham, da musicisti come Michael Nyman e Luc Ferrari, a artisti come Steve McQueen, Mike Kelley, Derek Jarman, Carsten Nicolai e Douglas Gordon. Dal 1991 è impegnato in concerti dal vivo, composizioni, installazioni e colonne sonore: gli album Mass Observation (1994), Delivery (1997) e The Garden is Full of Metal (1998) sono stati definiti dalla critica come lavori fondamentali per la scena musicale elettronica contemporanea. Nel 1994 il lavoro Sound Surface, realizzato con Stephen Vitello, è stata la prima colonna sonora commissionata dalla prestigiosa Galleria Tate Modern di Londra. Ha esposto e creato lavori nei più prestigiosi spazi dell’arte contemporanea, tra i quali il SFMOMA negli Stati Uniti, l’Hayward Gallery di Londra, il Centro Pompidou di Parigi, la Tate Modern & Tate Britain di Londra, il Palais des Beaux-Arts di Lille, il Kunsthalle di Vienna, il Bolshoi Theatre di Mosca e la Royal Opera House di Londra. Il suo lavoro è stato presentato negli Stati Uniti, in Sudamerica, in Asia, in Australia e in Europa. Già ospite a Lenz Teatro nel 2007 per la rassegna “As a Little Phoenix” e protagonista dell’edizione 2007 del Festival Natura Dèi Teatri con la performance From the Head to the Hip, per l’edizione 2008 del Festival ha realizzato le musiche originali di CONSEGNACI, BAMBINA, I TUOI OCCHI, creazione di Lenz Rifrazioni da La Ballata di Cappuccetto Rosso di Federico García Lorca. Per l’edizione 2009 del Festival Natura Dèi Teatri ha creato la performance Landscape & Memory. Nel 2012 ha realizzato progetti musicali per le olimpiadi a Londra.
More info: Facebook Twitter Website Soundcloud Flickr
Il mancato Re Lear di Verdi, ricostruito da Lenz Rifrazioni
di Giuseppe Distefano, Il Sole24ore, 17 ottobre 2015
“O terra, rigetta dal grembo i defunti!”. È il canto iniziale che s’ode nel silenzio. Sono figure fantasmatiche, apparizioni della mente di un sogno/incubo, quelle che vibrano nello spazio cupo di una stanza abitata da una sedia a rotelle a guisa di trono, e da due file di letti ospedalieri con manti di pelo nero su cui giacciono persone in carne ed ossa, ma che appartengono al regno dei morti. Appena sfiorate da una mano che le richiama in vita, una ad una prenderanno consistenza di personaggi per dire, per essere, per rievocare. Sono gli attori “sensibili”, segnati nella mente e nel corpo, la cui partecipazione restituisce la verità psicofisica alle diverse rappresentazioni della follia presente nella vicenda di “Re Lear”. Incarnano la durezza dell’esistenza reale e del dramma scespiriano, del sovrano raggirato dalle figlie adulatrici a cui ha diviso il suo regno dando loro fiducia per superbia, rinnegando invece l’unica figlia sincera e fedele, Cordelia, da lei infine soccorso nella pazzia dell’errante e della senilità precoce per lo sbaraglio del tradimento. Artisti di indiscussa qualità registica e scenica per unicità di lavoro e di ricerca, Francesco Pititto e Maria Federica Maestri di Lenz Rifrazioni, sono gli artefici di questa importante e ambiziosa operazione teatrale-installativa che scardina ogni linearità narrativa a favore di un’immersione visiva e uditiva, “immagine sonora dal potenziale atmosferico”, che ingloba parole, immagini, corpi, canto, e musica, in un unicum drammaturgico. Due allestimenti in un unico allestimento, con il pubblico che transita in due luoghi, con uno scambio di sala tra il primo e il secondo atto: due percorsi nel percorso verso la ricomposizione di un’opera incompiuta, ovvero quel “Re Lear” mai musicato a cui Giuseppe Verdi si dedicò senza portarlo a compimento e del quale esiste solo il libretto di Antonio Somma contenente le correzioni dello stesso compositore. Pititto e Maestri si sono avventurati in una “impossibile” invenzione-ricostruzione mettendo in scena, nell’ambito del Festival Verdi 2015 di Parma e Busseto, “Verdi Re Lear – L’Opera che non c’è” attingendo a frammenti sparsi, a presenze virtuali di altre opere dove vive la tragedia della paternità e della follia. La scrittura performativa – che si anima dentro la scatola scenica di velari grigi trasparenti dove, ingrandite, ci “guardano” le immagini reali e virtuali dei volti -, vive della musica del noto compositore elettronico inglese Robin Rimbaud aka Scanner. Questa s’intreccia con gli echi di musiche verdiane creando una densità sonora dove s’innestano arie d’opera eseguite da due soprani e due baritoni in scena, doppi Lear insieme, infine, alla presenza di Rocco Caccavari, (medico ed ex deputato per tre legislature), il cui volto segnato dalla sofferenza dice più di qualsiasi parola. Nel passaggio nell’altro luogo della rappresentazione domina la visione pittorica-installativa di un gruppo immobile disposto attorno a un trono sul fondo, reso evanescente dai velari trasparenti dove, a più livelli di proiezioni, scorrono le immagini di Lear, di cui udiamo la voce. Sui dettagli del suo corpo, raggomitolato, indugia la telecamera quasi a farne una mappatura dei moti e delle ferite dell’anima. Il re riassume la storia di padri e figli travolti da follia e cecità, in un grumo di affetti traditi. Ad aprirli è l’avanzare dell’attrice sensibile Barbara Voghera, la cui voce e presenza, trascinando poi una corda al guinzaglio, si riveste di quella verità autentica che vede nel fool, nel buffone, l’unico a potersi permettere parole vere. L’altra figura recitante che vaga è Cordelia (Valentina Barbarini) con indosso una pelliccia che deporrà sulle spalle del fool, non più figlia ribelle ma espressione di grazia. Ampliandone ulteriormente l’indagine, ecco conferire al Lear shakespeariano, oltre alla follia l’inedita dimensione di madre, che si carica così di dense rifrazioni drammatiche e simbolici affondi di senso, dopo aver cantato “Condotta ell’era in ceppi” del Trovatore, il ricordo tremendo della madre, con parole del Re: “Dov’è che sono stata? Dove sono?…”. In questo poetico e continuo cortocircuito tra i versi del libretto dell’opera e quelli del testo di Shakespeare, si addensano intrusioni visive e musicali dai potenti rimandi. Come le iniziali note elettroniche dell’inno italico di Mameli che non riesce a completarsi, mentre a terra, seminudi, si agitano in plastiche deposizioni i due baritoni – doppi Lear – e Cordelia.
Verdi Lenz Re Lear
di Rossella Menna, Doppiozero, 15 ottobre 2015
Perfino i grandi capolavori, quelli che di fatto, nei secoli, continuano a nominare misteri attraverso la precisione di forme magiche, sono solo rigurgiti di un grande silenzio, slanci incoscienti, interruzioni, dimenticanze – miracolose, poiché davvero inspiegabili – dell’afasia che caratterizza la vita di chi passa la vita a convocare vuoti. Più spesso vince l’afasia: gli aborti superano di gran lunga le nascite. L’artista abortisce di continuo, e quanto più crea più abortisce, poiché ogni nascita produce un fallimento, ogni slancio testimonia una inadeguatezza, tradendo la vertigine che l’ha sospinto in forma; ed è sempre più difficile: ma il dolore, appunto, a tratti si dimentica, per fortuna. E nascono La Sonnambula e la Norma in cui ci sono frammenti di un Ernani che Bellini non è mai riuscito a scrivere, per esempio. E Rigoletto, Il trovatore, Nabucco, La forza del destino, dai semi di un desiderio incompiuto di Giuseppe Verdi che per tutta la vita ha progettato di scrivere un’opera dal Re Lear di Shakespeare, lo slancio insuperabile, il suo capolavoro. Dell’opera fantasma – non incompiuta, ma abortita, appunto – resta unicamente il libretto di Antonio Somma, con le correzioni, massicce, del compositore. Gli aborti di opere liriche di cui esistono solo i libretti, sono terra di nessuno: snobbati dai musicologi che non si interessano a ciò che non è musicato, ignorati del tutto dai teatrologi che all’opera lirica non si interessano affatto. Eppure, tra le righe delle correzioni, nella relazione tra drammaturgo e compositore, dentro l’officina di un futuro aborto, c’è un potenziale di senso enorme: ci sono le tracce ancora vibranti della disperata smagliatura di un limite da parte di un artista. C’è la sua relazione con il mondo, prima che si perfezioni in una scoria. E dal momento che “nulla è, tranne ciò che non è”, per citare proprio Shakespeare, nel Re Lear che non c’è c’è Verdi, che è il Re Lear tradito dalle figlie a cui ha dato fiducia per superbia, soccorso invece dall’unica figlia fedele, esiliata; non per sovrapposizione tematica, ma per investimento desiderante, poiché l’accerchiamento stesso di una assenza sprigiona la presenza più sincera. Verdi Re Lear si chiama infatti l’opera verdiana assente che Lenz Fondazione, collettivo fondato e diretto da Maria Federica Maestri e Francesco Pititto, dal 1985 attivo nel campo delle visual performing arts, esplorando il linguaggio contemporaneo a livelli altissimi, ha presentato – significativamente – nell’ambito del Festival Verdi 2015 di Parma e Busseto. Tutto sommato è comprensibile che solo a degli artisti possa venire in mente di accostarsi ai fantasmi di un altro artista, e d’altro canto, solo l’energia di una approssimazione, il pathos di una distanza, la precisione e l’evanescenza di una forma che desidera può evocare un precedente accerchiamento, un altro desiderio, appunto. Il pubblico transita da una prima stanza a una seconda abitando un’unica installazione, senza consequenzialità, dalla sala del colore a quella del bianco e nero o viceversa, dal canto pronunciato da una bocca visibile, a quello solo udito, suggerito come ricordo, da sequenze logiche che parlano di potere, scettri e tradimenti, a sovrapposizioni, innesti, ombre. Lo spettatore insegue, riconosce, si perde, intuisce, come in un incubo, che a tratti è di Lear, ma di Verdi, o invece di Cordelia, o il nostro, o non si capisce più di chi, che non inizia e non finisce, ingoia e restituisce ossessioni, insistenze, paure, abbandoni, tenerezze, struggenza, frammenti di parole di cui spesso, soprattutto se a parlare è il fool–Barbara Voghera, ormai storica straordinaria attrice “sensibile” di Lenz – rimane solo l’ossatura vocalica, il balbettio, nello sforzo del pronunciare, del riconquistare di forza una corporeità, un senso viscerale a parole il cui significato dice solo storielle. In una delle sale, in una doppia proiezione, su due retinature che si sovrappongono in profondità, un uomo nudo accovacciato al suolo, Lear, compatisce, letteralmente, ciò che avviene in scena, tra le due retinature; la sottrazione del regio scettro pronunciata da due cantanti lo ferisce, proprio mentre lo vediamo follemente versare sulla propria testa del liquido nero, nero come i capelli neri di un re giovane e ancora sovrano, nero come la sua peluria, che si fa pelliccia nera che prova a vestire tutto, a riguadagnare il potere perduto. Il canto d’addio di Cordelia esiliata, “pellegrina ed orfana” come nell’aria della Forza del destino, fa contrarre il suo ventre, la voce di lei sembra scavare come un sondino nel corpo di lui, l’occhio della telecamera, la cui azione sembra essere controllata direttamente dalle altezze e dalle volute della voce, scava fin dentro i pori della pelle; e ancora, non capiamo se sia il canto a scuotere il corpo, come un’accusa, o il corpo, nell’atto stesso di muoversi, a produrre suono con il movimento, l’oscillazione, a rigurgitare il canto, come un rimorso che arriva dalle viscere; vediamo e sentiamo, indistintamente, comprendiamo per sinestesia, poiché siamo compresi. Sintesi, indiscrezione, massa, evanescenza, contraddizione e chiarezza, vastità e precisione: davvero come in un sogno, ma con il rigore linguistico attraverso cui il teatro può convocare i fantasmi. Proprio allo squadernamento della forma, insistendo in una pratica di riflessione teorica che negli anni è diventata consuetudine per la compagnia, Lenz ha dedicato un convegno intitolato ai Teatri del suono, coordinato da Enrico Pitozzi, docente dell’Università di Bologna, e curato da Valeria Borelli con ospiti Helga Finter dell’Università di Giessen e Massimo Marino, docente e critico teatrale. Un’occasione estremamente preziosa e rara, per riassumere, sintetizzare e condensare in un discorso a più vociriflessioni già piuttosto strutturate, dal punto di vista scientifico, circa il potenziale drammaturgico del suono nel teatro contemporaneo; ma più precisamente sullo slittamento, sulla frattura epistemologica che si è prodotta rispetto allo statuto stesso di ciò che si riconosce in quanto teatro, teatralità, con lo scarto innescato dalla performatività, dal superamento dell’istanza di rappresentazione in favore di una istanza di autoreferenzialità; un superamento che nella voce – in quanto suono che rimanda a se stesso prima che a un significato –, nella dimensione del vocalico come corpo, vita che pulsa prima e tra le maglie delsignificato verbale,ha trovato un viatico eccezionale. Verdi Re Lear offre, evidentemente, l’occasione perfetta per provare a chiarire il punto. Lenz esplora lo iato tra il desiderio e il compimento che non avviene (e che per statuto non deve avvenire), muovendosi tra i sospiri, nell’accadimento dell’esperienza prima che si esponga al giudizio e muoia, evocando le escrescenze sensibili dell’inconsolabilità dell’artista, i capolavori, le arie e i duetti dal Nabucco, daRigoletto, da La forza del destino, da Luisa Miller (ma non solo), opere – rintracciate da Carla Delfrate, cui Pititto e Maestri hanno affidato la ricerca musicale –in cui sono disseminati alcuni elementi di quel desiderio originario. Un Verdi reale è innestato dentro un Verdi in potenza, secondo un singolare procedimento di sottrazione: l’opera reale viene depauperata della musica per dare un corpo a un’opera inesistente: togliere un oggetto proprio mentre lo si nomina, per produrre vuoto desiderante, unheimlich, perturbanza. Più nel dettaglio, la dimensione sonora dell’installazione si sviluppa secondo un doppio tracciato. Da un lato Robin Rimbaud aka Scanner, uno dei compositori più importanti della scena elettronica mondiale, imprime il colore alle scene (e proprio in termini di colori confessa d’aver dialogato con Pititto in fase di creazione), quasi assumendosi la responsabilità diegetica, suggerendo continuativamente allo spettatore l’intreccio delle atmosfere, il pericolo, l’accadimento, la disperazione; in qualche modo recuperando la vocazione lirica dell’opera, il potenziale asemantico, commovente del melodramma. Dall’altro i frammenti verdiani cantati dagli allievi del Conservatorio Arrigo Boito di Parma (con la consulenza di Donatella Saccardi) – che sembrano invece non più suggerire le atmosfere della scena ma sporgere da dentro come schegge impazzite –, privati della musica, perdono proprio quel potenziale asemantico nella sua qualità originaria, per acquistarne una nuova, attraverso un strategia altra. La melodia che il canto a cappella conserva, infatti, facendo anche leva sull’archeologia che è nella mente dello spettatore, sul ricordo di quelle arie e quei duetti accennati, suggerisce un pieno mancato; è il silenzio dove ci si aspetta un rumore a effondere senso e commozione, a frustrare la percezione, a suonare; di «peso di una assenza di una musica nominata», parla più precisamente Federica Maestri. Ricapitolando: mentre il disegno sonoro di Skanner ci chiarisce che siamo dentro un sogno/incubo, i relitti delle opere verdiane ci costringono a esperire lo stesso vuoto desiderante di una composizione abortita. E davvero non si riesce a immaginare una forma più precisa per evocare l’impossibilità, il deserto sconfinato della vita in cui abitano Lear, Verdi, Lenz e noi.
Verdi Re Lear. Festival Verdi
di Daniele Rizzo, Persinsala, 14 ottobre 2015
È una (discutibile) convenzione ormai canonicamente accettata quella che segna nell’età risorgimentale della seconda metà del XIX secolo l’avvio della Storia d’Italia con le ideologie di patria e nazione, i movimenti di popoli e di idee, le circolazioni di merci e persone indiscusse protagoniste dei discorsi di storici, intellettuali e politici. Al club dei padri si iscrive necessariamente Giuseppe Verdi, tra i compositori più grandi di sempre, maestro di livello internazionale per tecnica ed eleganza esecutiva, nonché incarnazione – non a caso al pari di Alessandro Manzoni – dello Spirito di una nazione, la cui identità culturale e sociale si palesò da subito tanto problematica, quanto con quella innaturale ovvietà che, come tutte le imposizioni dall’alto, fu figlia di necessità politiche volte incoerentemente e/o paternalisticamente al bene comune, essendo in realtà espressione del blocco storico ormai dominante (la borghesia). Con un drammatico ribaltamento di priorità (in primis l’Italia, poi gli italiani), l’Unità fu, soprattutto a livello popolare, vissuta quale dominio da parte di chi pensava che, «fatta l’Italia, fare gli italiani» fosse una sorta dimission laica (Mazzini), economica (Cavour) o religiosa (Manzoni), così edificando il primato storico dell’essenza sull’esistenza, del dover essere sull’essere autenticamente. Disvelando – attraverso l’arte – il complesso rapporto tra normalità e diversità, tra cultura e potere, tra norma e rivoluzione, quella antinomia si destruttura sul solco delle analisi di Lenz delle origini della nostra cultura, il cui conformismo (reale e drammaturgico) ha ridotto al soliloquio un intero mondo di shakespearean fools ritenuto non funzionale ai meccanismi e ai dispositivi di produzione e omologazione. Sfuggendo a ogni tentazione dicaduta estremistica e compensandosi in un fantastico equilibrio tra ricerca estetica ed analitica esistenziale, quello raggiunto da Francesco Pititto e Maria Federica Maestri è un compiuto formalismo. Audace nello spingersi oltre, cosciente nel fissare la propria direzione drammaturgica e sempre mirabile nel restituire capolavori della cultura nazionalpopolare in vesti rinnovate e perfettamente aderenti, lo abbiamo ammirato da I Promessi Sposi all’Adelchi, fino a Il Furioso (da Ludovico Ariosto), esemplari diversamente modulati di una poetica in grado di sfoggiare vertici assoluti in termini di esperienza e qualità attorale, registica e scenica. Da tali premesse archeologiche (culturali e teatrali), ma con un inedito privilegio accordato alla resa estetica, prende corpo Verdi Re Lear – L’Opera che non c’è, ambizioso progetto volto alla realizzazione di ciò che rimase incompiuto, dunque non esistente e impossibile da porre definitivamente di fronte agli occhi: l’opera di Giuseppe Verdi «mai musicata e di cui esiste solo il libretto di Antonio Somma contenente le correzioni dello stesso compositore». La dimensione itinerante – che, per esempio, ne I Promessi Sposi costituiva la declinazione immersiva attraverso cui dare corpo alla responsabilità del pubblico – viene spezzata senza essere interrotta, resa anch’essa incompiuta perché affidata alla centralità della prospettiva di visione e confinata al momento di cambio di sala tra il primo e il secondo atto, la cui successione diacronica puramente casuale (a sorteggio) scardina aprioristicamente ogni aspettativa e intreccio narrativo. Due allestimenti nell’allestimento, dunque, che, grandiosi nell’intenzione e titanici nella realizzazione, hanno visto la splendida collaborazione del Conservatorio di Musica A. Boito di Parma con la consulenza musicale di Carla Delfrate, quella al canto di Donatella Saccardi, e la partecipazione di eccellenti cantanti lirici. Ad accogliere i due gruppi di spettatori sono cast e scenografie diverse. I primi – pur nella diversità tra gli atti – sono abitanti erranti di un mondo cui sono con-segnati per inscenare «la materialità dei corpi che, dialogando con l’immaterialità dell’immagine, genera un’immagine-sogno», realistici brandelli del rapporto asintotico tra libertà e dovere, tra ragione e follia, tra naufragio dell’ego e deriva dei sentimenti, ovvero di quella tragedia dell’eccesso e dell’eccedenza che fu il King Lear del Bardo. Le seconde, entrambe poste oltre «velari trasparenti» su cui – a seconda della sala – si vedranno agire corpi e volti in proiezione, colpiscono per la diversità e l’efficacia dell’impatto visivo, ma, forse e ancor di più vista la commistione di sensibilità in scena, per la comune capacità di concorrere alla costruzione di una tipica veste operistica povera, condividendo tale merito con la densità sonora delle rivisitazioni verdiane di Scanner, strabilianti per come riescono letteralmente a vestire i volti e le interpretazioni di differenti tonalità caratteriali e drammatiche. Una rappresentazione, allora, «impassibile e si divide, si sdoppia, senza rompersi, senza agire, né patire» (Gilles Deleuze, Logica del senso), che, nonostante una diversa impressione di omogeneità, dalle strepitose geometrie e coralità della Sala Est all’intensità plastica a tratti calante della Sala Majakovskij, si pone in sublime coerenza con il progetto di Lenz Fondazione, testimoniando in pieno la forza, l’urgenza e la potenzialità dell’arte quale strumento espressivo e contesto non coercitivo in cui lasciare che ognuno possa realmente affermare «diventa ciò che sei».
Verdi reloaded. Il Re Lear secondo Lenz Rifrazioni
di Andrea Alfieri, Krapp’s Last Post, 22 ottobre 2015
Il più grande affresco drammatico di Shakespeare: una Britannia mitica in cui un vecchio re non sa distinguere tra il falso e autentico amore delle sue tre figlie, e lo stesso sovrano che muore di dolore. Sono queste scene così potenti che devono aver convintoGiuseppe Verdi a tentare di musicare il Re Lear. Un tentativo rimasto incompiuto, e il fantasma del re britannico continuerà ad aleggiare inquieto in diverse opere del Maestro. Lenz Rifrazioni rievoca questo fantasma dell’opera rintracciando gli spettri del desiderio creativo verdiano. Lo fa collaudando i linguaggi contemporanei della drammaturgia, delle scenografie reali e virtuali, della musica, e del corpo performativo, spingendo la ricerca in nuove configurazioni di intreccio con il melodramma. Inserito come coproduzione nel cartellone del Festival Verdi 2015 di Parma, il Re Lear di Lenz è uno spiazzante incontro tra le poetiche di confine dell’arte performativa della compagine parmense, e l’incorruttibile tradizione lirica del Teatro Regio. L’esito è una contaminazione semiotica tra rincorse di sperimentazioni sonoro-visuali, e i ricorsi ossessivi che Verdi diffuse in numerose sue arie in omaggio all’opera shakespeariana. È un esito che transita in una duplice installazione scenica, allestita in due sale distinte, dove si replica contemporaneamente la performance, e gli spettatori che si spostano casualmente da un luogo all’altro. Non c’è una consequenzialità narrativa, è il pubblico che passa da una modalità immersiva ad un’altra. I due quadri vivono di vita propria, indipendenti ma in simbiosi, una duplicità convivente a cui lo spettatore è chiamato a testimoniare, a variare la propria prospettiva in un accumulo fluttuante di segni. Entrambe le scene sono raccolte in un involucro di drappi in trasparenza, stratificati su più livelli, sono l’habitat di materiali visivi diluiti nella frammentazione dell’agire. Sono video che simultaneamente evocano un’assenza, un re nato ma senza mai essere stato concepito, volti sospesi appartenenti a territori sfuocati, immaginati ma mai decriptati. Indefiniti come in un sogno, ma concretamente ossessivi nel loro ispezionare i ricordi di un’umanità. È un gioco multivisivo che porta a rovesciare le dinamiche della visione, è la scena che guarda il pubblico. Le due installazioni si distinguono per un binomio colore opposto al bianco e nero, e per una ambientazione simulacro monumentale opposta a una squadrata sala ospedaliera, dove due file di letti accolgono i corpi dei performer avvolti in pesanti coperte nere. Mentre l’unicità della rappresentazione si manifesta nei magnetici echi di suoni, voci e sospiri, e in una liturgia salmodiante che gli attori cospargono nelle maglie di una drammaturgia che si intravede (del resto dell’opera ci è comunque pervenuto il libretto di Antonio Somma, con le correzioni in continuo divenire del compositore). Attori che, come sacerdoti, liberano un rito pulsante di materia sonora, apparendo e disgregandosi in una cerimonia creatrice di bagliori letterari. Agli storici interpreti e attori sensibili di Lenz si intrecciano cantanti lirici, allievi del Conservatorio Arrigo Boito di Parma, che innestano i presagi di una partitura assente ma delineata dal potente spirito verdiano che soffia sulla messa in scena.
Potente come l’impronta delle elaborazioni sonore del sound artist di culto Robin Rimbaud aka Scanner, già prezioso collaboratore in diverse occasioni della compagnia. L’artista inglese amalgama un contesto di rivisitazioni elettronico-sperimentali verdiane che dilata la funzione di accompagnamento, rivestendo il formato operistico con un reticolato di immaginificazioni sonore, alimentate da compiute arie del compositore parmense, ma che ridisegnano i colori musicali, esplorando i prismi di una vera e propria drammaturgia acustica. La musica come sistema nervoso dell’organismo performativo. La messa in scena non concede nulla alla linearità descrittiva, procede prevalentemente per connessione di quadri, movimenti frammentati in una circolarità di simbologie visionarie, in cui il pubblico viene idealmente internato e lasciato inerme al tentativo di estendere la percezione visivo-uditiva.
L’intenzione non è certo quella di restituire una ricostruzione anche solo intuita di un’opera mai composta, assente quindi, ma l’elaborazione ex novo del feto di un processo creativo latente e latitante. Non sarebbe privo di esiti interessanti un più frequente connubio tra questo genere di progetti e il fin troppo imbalsamato mondo dell’opera lirica.
C’è un Verdi che non c’è sul pentagramma della lirica. È il Re Lear da quel William Shakespeare che permise al cigno di Roncole di Busseto di dimostrarsi grande oltre lo spirito del suo tempo, il patriottismo, i moti rivoluzionari del ‘48, l’Italia e gli italiani da fare. Esiste il libretto, mentre la musica è “il fantasma di un’opera”, come dice Mario Lavagetto, che infesta e informa di sé, come un desiderio o forse un’inquietudine, Nabucco, Luisa Miller, Rigoletto, Trovatore, La forza del destino. Qui, in questa ‘casa stregata’, dove i lenzuoli sono sipari, le catene sono note musicali, e la volontà prende sempre le misure di un qualche palcoscenico, sono entrati Francesco Pititto e Maria Federica Maestri, cioè Lenz Fondazione di Parma, e insieme al compositore di musica elettronica Robin Rimbaud aka Scanner e ai cantanti del Conservatorio “Arrigo Boito” hanno trovato, scoperto cercando, o più precisamente sono giunti alla meta del Verdi Re Lear. Dopo la Premessa nella scorsa edizione del Festival Internazionale Natura Dèi Teatri, l’ambizioso progetto di teatro musicale è stato proposto nella sua forma definitiva nell’ambito del Festival Verdi 2015. Un’impresa che poteva nascere, crescere e realizzarsi solo con Lenz, forte della propria esperienza nel liberare tutte le opportunità di bellezza chiuse nella mancanza, nell’assenza, come dimostra il lavoro con gli attori ‘sensibili’ – con disabilità psichica e intellettiva – e la pluriennale collaborazione con il Dipartimento assistenziale integrato di salute mentale dipendenze patologiche dell’Ausl parmense.
La tragedia della paternità nell’intimo del re/padre/folle, delineata da Salvadore Cammarano, già autore del Trovatore, e portata a termine da Antonio Somma, librettista di Un ballo in maschera, si divide nelle sale dello spazio post industriale di Lenz Teatro, la Sala Majakóvskij e la Sala Est: agiscono e si ripetono, contemporaneamente, inizio, svolgimento e fine, la divisone del regno, l’esilio di Cordelia, il conte di Gloucester e i suoi figli, la pazzia e morte di Lear. Il pubblico di una sala, al termine della performance, si sposta nell’altra: la non presenza di una linearità narrativa è lo specchio dell’impossibilità di ricostruire un’opera mai composta, se non appunto interpretandola, inventandola attraverso cambi di posture mentali (e fisiche), luoghi, sguardi, gli stessi che si chiedono anche al pubblico, qui autore più che mai. Il virtuale e il reale della scena resi dalla drammaturgia, imagoturgia e regia di Francesco Pititto e dalle installazioni e dai costumi di Maria Federica Maestri, sono i molteplici frammenti linguistici ed espressivi a cui lo spettatore è chiamato a dar la forma dell’incessante ricerca creativa di Verdi. La musica è quella di Scanner, le arie e i duetti selezionati dal M° Carla Delfrate, secondo una griglia di affinità e rimandi al rapporto padre-figlio e ai temi dell’inganno, del potere, della vecchiaia, dell’incomunicabilità, sono a cappella, perché del Lear restano solo le parole, è un paesaggio di cui esiste soltanto la mappa, un territorio che non riusciremo mai a trovare, pur sapendo dove andarlo a cercare.
Sala Majakóvskij < Tre schermi grigi e trasparenti, uno dietro l’altro, e in fondo il trono ricoperto di mantelli neri e pelosi, sono la radura selvaggia tra sogno e realtà aumentata, tra azione e immaginazione, in cui Lear chiede alle tre figlie chi lo ama di più. Il Re è una voce (di Rocco Caccavari) che cade dall’alto e l’immagine di un corpo-mondo, nudo, che non ha più nulla, che ha perso il peso di tutto. Questa proiezione diventa porta e finestra, la siepe oltre cui guardare il canto del fato inesorabile di Cordelia “pellegrina e orfana” come ne La forza del destino. Immobili e ferme, le voci dei cantanti preparati dalla prof. Donatella Saccardi vibrano le note nell’aria fino all’ultimo, estremo addio. Assonanze magnetiche, quasi magiche, guidano una sovrapposizione di piani d’ascolto e confronto concentrici come cerchi nell’acqua. Luce e lamento, sensualità paurosa e lo sguardo verso chi non c’è, più. La solitudine è inferta a Lear e il cordone ombelicale è un cappio stretto al collo del Fool interpretato dell’attrice ‘sensibile’ Barbara Voghera: ciò che è nella testa non esce se non a costo del dolore.
Sala Est < Una teoria di 10 lettini ospedalieri, 5 per lato, ricoperti dei soliti manti neri e pelosi, uno schermo trasparente grigio a chiudere la scena e uno più piccolo in fondo, sono il labirinto dell’infermità, il limbo, la tempesta dei sensi reduci dalla guerra interiore dell’anziano re. Si ripercorre la genesi del dramma, il processo istruito da Lear alle figlie Nerilla e Regana, e l’incontro, non presente nel libretto originario, con Gloucester nella brughiera, accomunati da cecità reale e cecità paterna. Le liriche verdiane e il live electronics di Scanner incontrano un ritmo concitato, di corsa contro il tempo, apocalittico, senza speranza. Ultimo uomo sulla Terra, Lear è assiso sul suo trono, una carrozzina. Roberto Caccavari, presidente onorario di Lenz Fondazione, ha una barba in chiaroscuro che pare scolpita nel ghiaccio e nel vento. La sua presenza si avvicina, si sovrappone e quasi entra dentro la sua immagine proiettata sullo schermo. Il volto, ripreso nel dettaglio, sembra solcato dai crateri della Luna, la bocca vera nella bocca filmata, che spalanca e spezza di luce il respiro come fa il faro con le onde nella notte. Resta lì, le figlie o i loro spettri accanto, e lancia i suoi occhi oltre la livida cortina: veniamo al mondo e piangiamo, “all fools”, tutti matti. La malattia umana è una tragedia cosmica su lidi affetti dal rimorso.
Verdi Re Lear di Lenz, un vademecum per gli spettatori
di Alessandro Trentadue, 14 ottobre 2015, La Repubblica
Verdi Re Lear è un’opera in cui Lenz ha “osato” tanto. E con la sua “follia” (quella “tempesta nella mente”) il teatro del Pasubio ha coinvolto innanzitutto il Teatro Regio, il festival Verdi. E ha perfino fatto sì che il Conservatorio cedesse al fascino del tanto “temuto” contemporaneo.
Verdi Re Lear di Lenz ha spiazzato diversi spettatori, immersi in una complessità di piani semiotici, in una una ricorsività sonoro-visuale. A cominciare dai due piani di Deleuze che si manifestano, forse per la prima volta in forma di rappresentazione scenica, con le due sale in cui l’opera si svolge contemporaneamente.
Per rispondere agli interrogativi di chi è andato a teatro – o andrà nelle ultime repliche – abbiamo pensato a un piccolo vademecum. Un breve decalogo con alcune riflessioni e considerazioni sull’opera, raccolte insieme a Francesco Pititto – regista, responsabile della ricerca, drammaturgia e imagoturgia dell’opera fantasma di Verdi – su come guardare il progetto di Lenz in scena al Festival Verdi 2015. E su cosa riflettere dopo aver assistito appunto al Verdi Re Lear.
– “Abbiamo voluto vestire un fantasma: qualcosa di intangibile. Shakespeare. Il tutto e il niente. Su quel fantasma abbiamo costruito un vestito fatto di segni linguistici, l’immagine, la musica elettronica di un grande compositore internazionale, gli attori, le voci dal vivo e registrate, compresi arie e duetti che appartengono a tante opere di Verdi. Verdi che ha stravolto Shakespeare. E che non ha scritto un rigo di Re Lear, ma ha disseminato questo desiderio in tante sue opere”.
– “Abbiamo dato corpo ad un’opera fantasma di Verdi: qualcosa che il Maestro stesso aveva già messo in moto, in maniera concreta, concatenamenti attraverso i quali poteva avvicinarsi ad esaudire quel desiderio”.
– Le tracce del Verdi “conosciuto” nel Re Lear. Nel Trovatore, con Azucena, c’è il dramma di un Re Lear femmina. C’è il complotto del Rigoletto. Il potere del Don Carlo. L’esilio padre-figlia della Forza del Destino (“Me pellegrina e orfana”). Il sogno e incubo di Francesco de i Masnadieri, Luisa Miller e tanti altri frammenti selezionati da una grande conoscitrice delle opere verdiane, Carla DelFrate.
– “Verdi si rese conto che il Re Lear era troppo innovativo per presentarlo a Parigi. Tanto che considerò i parigini ‘non pronti ad accoglierlo’, e preferì mettere in scena il Don Carlos”.
– “Occorre vedere il Verdi Re Lear come si guarda una giostra per bambini, con i cavallini. Ogni cavallino è un segno, diverso per forma e colore, un seméion. La giostra gira, gira e girando non vediamo più i tanti cavallini ma solo uno che li contiene tutti, un solo cavallino che diventa la somma di tutti quei segni”.






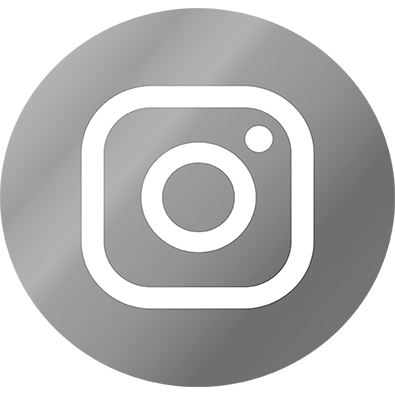






































![[cml_media_alt id='4756']Robin Rimbaud aka Scanner copia[/cml_media_alt]](https://lenzfondazione.it/wp-content/uploads/2014/11/Robin-Rimbaud-aka-Scanner-copia-300x236.jpeg)

